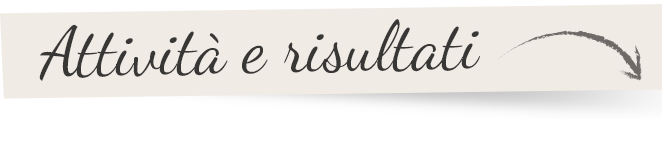Nadiya Dunayevska, giovane ricercatrice del progetto SOS-KIWI, ha presentato i risultati del suo lavoro al Convegno AISSA Under40. In questa intervista, racconta con entusiasmo il percorso che l’ha portata nel mondo della ricerca, fornendo spunti utili a chi vuole vincere nuove sfide.
Il VI Convegno AISSA Under40 si è svolto il 5 e 6 giugno 2025 presso la sede del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel suggestivo contesto del Real Sito Borbonico della Reggia di Portici (Napoli). L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto per giovani ricercatrici e ricercatori desiderosi di arricchire le proprie competenze, condividere conoscenze e presentare i risultati delle proprie attività scientifiche nell’ambito delle scienze agrarie.
Il tema di questa edizione è stato “Le Scienze Agrarie per Coltivare il Domani: Sostenibilità e Innovazione in Agricoltura”. In questo contesto si è inserita la presentazione dei primi risultati del progetto SOS-KIWI, finalizzato a contrastare la moria dell’actinidia attraverso strategie di prevenzione e difesa, con l’obiettivo di limitarne la diffusione e migliorare la salute delle piante.
La conferenza ha offerto l’opportunità di conoscere meglio Nadiya Dunayevska, giovane assegnista post-laurea presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che ci ha raccontato il suo contributo nel progetto SOS-KIWI e il percorso che l’ha portata a occuparsi di ricerca agraria.
Nadiya, puoi raccontarci in poche parole di cosa ti occupi?
Le mie attività di ricerca si concentrano sull’identificazione di strategie biologiche, in particolare l’uso di batteri promotori della crescita vegetale per supportare le piante di actinidia nella difesa contro la moria del kiwi.
Che cosa ti ha spinto a scegliere questo tema di ricerca?
Sono stata sicuramente motivata dalla possibilità di unire il lavoro in laboratorio alle osservazioni in campo. Inoltre, il tema della moria del kiwi è attuale, rilevante e concreto considerando il suo impatto nel settore agroalimentare, sia a livello produttivo che ambientale.
Nel tuo poster fai riferimento allo sviluppo di un consorzio microbico. Di cosa si tratta esattamente?
Si tratta di una formulazione composta da microrganismi PGPR (promotori della crescita) selezionati in base a specifiche proprietà nutrizionali e metaboliche e che per questo possono migliorare lo stato fisiologico e la resistenza agli stress biotici e abiotici. La formulazione che abbiamo studiato per le nuove sperimentazioni nell’ambito del progetto è stata sviluppata tenendo conto sia dei fattori di stress che precedono la comparsa della sindrome, sia della necessità di garantire un rilascio graduale dei batteri selezionati, così da favorire una colonizzazione efficace del suolo.
Come si “costruisce” un consorzio microbico efficace?
Si tratta di un processo ambizioso e complesso che richiede diverse fasi: dall’isolamento e caratterizzazione dei ceppi microbici, alla valutazione delle loro proprietà in vitro, fino alla verifica della loro efficacia in condizioni controllate e successivamente in campo. I ceppi devono essere compatibili tra loro e capaci di instaurare un’interazione funzionale con la pianta ospite e l’ambiente radicale.
Secondo te, quanto è vicino l’uso pratico di questi consorzi microbici in agricoltura?
L’utilizzo di consorzi microbici è già ampiamente diffuso in agricoltura biologica, anche su larga scala. Per quanto riguarda il nostro consorzio sono però necessari ulteriori test in serra e in campo prima di una potenziale applicazione da parte dei produttori.
Quali vantaggi concreti potrebbe avere questo approccio per gli agricoltori?
L’utilizzo di consorzi microbici può ridurre la dipendenza da fertilizzanti chimici, migliorare la salute del suolo e la resilienza delle piante. Questo si traduce non solo in benefici ambientali, ma anche in vantaggi economici per gli agricoltori: minori costi di input e maggiore stabilità delle rese, grazie a colture meno vulnerabili agli stress. Inoltre, adottare soluzioni biologiche può favorire l’accesso a mercati sempre più orientati verso criteri di sostenibilità, generando un valore aggiunto per le produzioni.
Avete già ottenuto risultati promettenti?
Sì, i dati preliminari mostrano una risposta positiva da parte delle piante trattate con il consorzio sviluppato. Inoltre, le attività svolte da me e dal gruppo di ricerca di microbiologia del Dipartimento di Agraria mostrano un aumento significativo dell’abbondanza di alcuni gruppi batterici, coinvolti nella salute e fertilità del suolo dove era stato applicato il consorzio microbico. Questo suggerisce un impatto positivo sull’assimilazione di macro- e micronutrienti.
Quali sono i prossimi passi del tuo lavoro?
Nei prossimi mesi ci concentreremo sul testare la formulazione sia in campo che in serra, per valutarne l’efficacia e la stabilità nel tempo. Un ulteriore approfondimento sarà lo studio dell’interazione tra il consorzio microbico e il microbioma del suolo, per comprendere meglio i meccanismi alla base dei benefici osservati.
Pensi che questo approccio possa essere esteso anche ad altre colture?
Assolutamente sì. Il principio alla base dell’uso di consorzi microbici – ovvero stimolare la resilienza delle piante in modo sostenibile – è applicabile anche ad altre colture soggette a stress simili, come vite, olivo o agrumi. Ovviamente, ogni coltura ha specifiche esigenze e interazioni, quindi è necessario selezionare e adattare opportunamente i ceppi microbici.
Qual è il messaggio che vorresti arrivasse al pubblico non specialista?
Mi piacerebbe trasmettere l’idea che soluzioni naturali e sostenibili sono possibili anche in un settore tecnologicamente avanzato come l’agricoltura. La ricerca scientifica può fornire strumenti concreti per affrontare sfide ambientali complesse, migliorando al tempo stesso la produttività e la salute del suolo.
Cosa ti entusiasma di più nel fare ricerca oggi? E cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere un percorso simile al tuo?
Ciò che mi entusiasma di più è la possibilità di contribuire concretamente a un’agricoltura più sostenibile, attraverso l’innovazione scientifica. Ogni fase della ricerca, dal laboratorio al campo, rappresenta una sfida. ma anche un’opportunità di apprendimento. Inoltre, poter presentare il mio lavoro durante il VI Convegno AISSA Under40 e confrontarmi con giovani ricercatori provenienti da tutta Italia mi ha permesso di ampliare la mia visione sulla ricerca agraria.
Ho ascoltato interventi su tematiche molto diverse – dall’innovazione genetica, alla sostenibilità in ambito zootecnico – e ho particolarmente apprezzato il clima di apertura e condivisione. Anche solo raccontare il mio progetto a chi lavora in ambiti diversi mi ha aiutato a chiarire meglio i punti di forza e le criticità del lavoro svolto.
A chi vuole intraprendere un percorso simile al mio consiglio di coltivare la curiosità, di non temere il confronto e di cercare ispirazione anche al di fuori del proprio ambito: la multidisciplinarietà è spesso la chiave per fare ricerca davvero innovativa.
A cura di Ida Romano, Università degli studi di Napoli Federico II e ricercatrice del progetto SOS-KIWI
Foto di copertina (fornita dall’autrice dell’articolo) che ritrae Nadiya Dunayevska a fianco del poster presentato al Convegno AISSA